Lo stretto legame tra le cose nel mondo, così come la vulnerabilità della vita, sono dolorosamente dimostrate a tutti in questi mesi dalla pandemia. Legame e vulnerabilità sono due parole chiave che hanno segnato anche l’Enciclica papale sull’ambiente, in cui Francesco nel 2015 chiedeva una responsabilità globale e un confronto sincero e chiedeva anche una nuova concezione dell’economia e del progresso.
Traduzione dal tedesco: Italo L. Cherubini

La casa del mondo
L’Enciclica Laudato Si’ nel suo sottotitolo esprime già l’unione e la stretta interdipendenza di tutto attraverso l’immagine del pianeta come casa comune.1 La casa sulla terra è «un luogo di vita per tutte le persone – e anche di più: per tutti gli esseri viventi […] in cui tutti hanno lo stesso diritto di vivere bene».2 Tuttavia, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo non solo limita la qualità della vita degli esseri viventi, ma porta anche molte persone a lottare per la sopravvivenza. La casa comune minaccia di diventare un deserto.
«Ogni anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre» (LS 33).

La perdita di biodiversità – già questo un male se consideriamo il valore intrinseco di ogni creatura – ha gravi conseguenze per tutta la casa. La scomparsa anche delle creature più piccole distrugge le catene alimentari e porta allo squilibrio di interi ecosistemi. Per le persone colpite, questo a sua volta significa povertà e migrazione. Chi vive in abbondanza spesso non comprende appieno le drammatiche conseguenze della crisi ecologica. Francesco sottolinea continuamente che l’inquinamento ambientale e il cambiamento climatico colpiscono in modo particolare i più deboli del pianeta e aumentano le disuguaglianze esistenti.3 L’umanità si trova ad affrontare un’unica e complessa crisi socio-ecologica (LS 136), e nonostante questo i più poveri tra i poveri hanno un ruolo poco rilevante nei dibattiti internazionali sull’ambiente.
Spreco di risorse
La perdita di biodiversità, l’inquinamento e il cambiamento climatico sono in gran parte causati dall’attività umana. L’impronta ecologica della società occidentale post-industriale è molte volte troppo accentuata. Il modo in cui ci nutriamo, produciamo e consumiamo si basa sullo spreco di risorse naturali. L’accelerazione di questi fenomeni ha contribuito a far sì che i limiti di sfruttamento siano già stati superati. Lo sfruttamento eccessivo distrugge la natura e va a scapito degli altri. Alla dimensione ecologica della crisi si aggiunge quella sociale e così i Vescovi neozelandesi si sono chiesti:
«cosa significa il comandamento “non uccidere” quando un venti per cento della popolazione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere.» (LS 95)

Tuttavia, la minaccia alla casa comune non si basa semplicemente sull’avidità personale o sull’irresponsabilità. La critica di Francesco mira all’ingiustizia delle strutture. Parla di una logica perversa che deve essere infranta: il potere della razionalità unidimensionale e tecnocratica.
Il paradigma tecnocratico
I piccoli sistemi agricoli, presi come esempio nell’Enciclica, sono minacciati costantemente in tutto il mondo. Alimentano la maggior parte della popolazione mondiale e utilizzano una proporzione relativamente piccola di suolo e acqua (cfr. LS 129). Ciononostante, i piccoli agricoltori sono stati costretti ad abbandonare il mercato. La causa della difficile situazione del pianeta è il trionfo della ragione strumentale, o come la chiama Laudato Si’, la subordinazione di tutti i settori della società a un paradigma tecnologico. La ragione tecnico-razionale si riflette solo sui mezzi, non sui fini. Incapace di guardare all’insieme, contano solo i propri interessi immediati.
«Il paradigma tecnocratico tende ad esercitare il proprio dominio anche sull’economia e sulla politica. L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. Non si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale.» (LS 109)

Il mito moderno della crescita illimitata e l’idea che la tecnologia sia la fonte della salvezza hanno fatto il loro tempo. La tecnologia tende a dominare la natura. Il rapporto puramente strumentale o tecnico con la natura mostra ovunque il suo aspetto più deteriore. «Quando si propone una visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la società» (LS 82), ammonisce il Papa e aggiunge: «Lo scopo finale delle altre creature non siamo noi.» (LS 83)
L’ecologia globale come contro-modello
La complessa crisi ambientale e il problema della povertà rendono necessario allargare il proprio orizzonte, pensare in modo trasversale e creativo. È necessario, secondo Francesco, guardare ai grandi obiettivi oltre gli interessi immediati. Quale sviluppo vogliamo? Cosa significa qualità della vita al di là della crescita e del consumo, e come possono partecipare tutti alla vita sociale? Papa Francesco chiarisce che non possiamo andare avanti come prima, perché così facendo possiamo solo «nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale» (LS 111).
«Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico.» (LS 111)
La responsabilità nei confronti delle generazioni future rende chiaro che la protezione dell’ambiente non è un comportamento opzionale. La terra appartiene anche ai nostri nipoti. Il Papa non si aspetta quindi dalla politica solo «discorsi patetici», ma un’azione decisa. Dal momento che «l’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente»4, sono necessarie istituzioni internazionali forti e accordi vincolanti con meccanismi di controllo.
Cambiamento dal basso

La speranza è data a Francesco soprattutto dai movimenti ecologici e dalle azioni sociali che per molti versi resistono alla logica tecnocratica. Il Papa conta su un cambiamento dal basso. Non c’è un solo modo giusto per interpretare e trasformare la realtà. Non vuole un nuovo universalismo. L’ecologia globale pensa localmente, valorizza le ricchezze culturali di tutti e presta particolare attenzione alle comunità indigene. Francesco è convinto che le religioni e le tradizioni mistiche possano dare un contributo essenziale alla cura della casa comune, dal momento che la crisi ambientale è anche una crisi spirituale. Per la fede, il mondo «è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode.» (LS 12) La gratitudine e la gioia per la creazione di Dio danno forza e motivazione per un approccio attento e sostenibile alla casa della terra e a chi la abita.
- Papa Francesco: Laudato Si’. Sulla cura della casa comune, 25. Mai 2015, su: http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. L’Enciclica Laudato Si’ sarà citata in seguito con LS e il numero relativo.
- LS 23. Cfr. Felix Prinz zu Löwenstein: Die globale Ernährung und Laudato Si’, in: Concilium 54 (2018), p. 586-593.
- Cfr. Capitolo 1 «Quello che sta accadendo alla nostra casa» (LS 17-61) e su questo anche Angela Büchel Sladkovic: Laudato Si’ (I), su: questioni-di-fede.ch
- LS 190. Cfr. anche: «Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale» (LS 109).
Crediti immagine: Immagine di copertina: Olafur Eliasson, «Escaped light landscape», Installazione 2020, Kunsthaus Zurigo. Lenti mobili che rifrangono prismaticamente un fascio di luce in fascio. L’installazione segue le leggi dell’ottica e si riferisce quindi al presupposto elementare di vedere. Per aguzzare lo sguardo. Immagine: kr; Immagine 1: iStock/manonallard; Immagine 2: iStock/Daynjer-in-Focus; Immagine 3: iStock/Dirk-Hinz; Immagine 4: iStock/Sanjeri; Immagine 5: kr




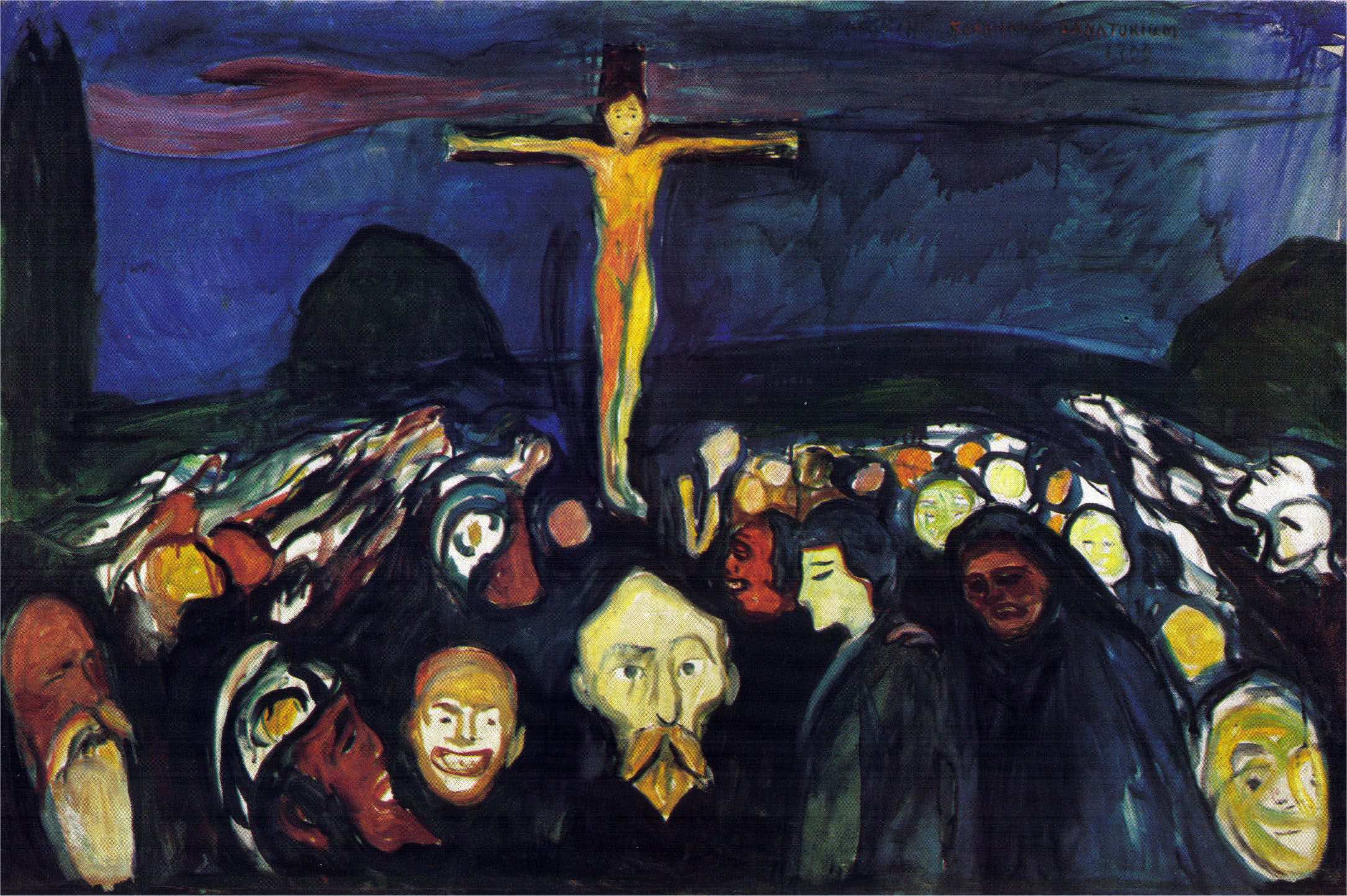
Commenti
Ancora nessun commento