Dio è attento alle vicende umane. Dio si lascia toccare e coinvolgere dalla vita umana, sia dalla gioia che dalla sofferenza. La gente ci crede quando prega e questo è quello che uomini e donne sperano quando portano le loro preoccupazioni e i loro bisogni davanti a Dio: le loro e quelle dei loro cari.
Traduzione dal tedesco: Italo L. Cherubini
Fede, speranza e carità: secondo la tradizione teologica, queste formano le tre virtù divine. La triade risale all’apostolo Paolo. In una lettera all’ancora giovane comunità di Corinto, riassume con la formula «fede, speranza, carità» ciò che è già donato ai credenti ora, in questo tempo, in questa vita. La comunità di Corinto può e deve vivere il proprio cristianesimo orientando le proprie azioni verso la fede, la speranza e la carità. Tuttavia, Paolo non si ferma a questa triade, spiega anche subito quale delle tre virtù è la più grande: «ma la più grande di tutte è la carità!» (1 Lettera ai Corinzi 13,13).
La carità mostra ciò che fondamentalmente vale anche per la speranza e la fede: non possiamo vivere da soli. La carità richiede almeno due persone: uno che ama e uno amato, per cui l’amato idealmente ama a sua volta. Per ciò che è essenziale nella vita, dipendiamo gli uni dagli altri. «Nessuno è un’isola»: questa è la conclusione raggiunta dal monaco trappista Thomas Merton (1915-1968) nelle sue riflessioni sulla carità.1
Nella vita come nella fede, siamo legati gli uni agli altri, siamo in molteplici relazioni. Nessuno ha la vita di sua propria volontà. Anche per la fede è vero che di solito sono altre le persone attraverso le quali abbiamo trovato accesso alla fede e che spesso le danno nuovi impulsi. Vivendo ciò che abbiamo quindi compreso dal Vangelo, noi stessi portiamo e diamo forma alla fede cristiana. È possibile che attraverso il modo in cui crediamo e coltiviamo la nostra fede, abbiamo già iniziato e messo in moto qualcosa in più persone, più di quanto ne siamo consapevoli.
L’amore mostra ciò che è fondamentalmente vero anche per la speranza e la fede: non possiamo farcela da soli.
Poiché nessuno è un’isola, è difficile immaginare la speranza senza il coinvolgimento di altre persone. Il nostro amore non è solo per noi stessi e per Dio, ma anche per molte altre persone. Hanno un posto nel nostro cuore. Di conseguenza, ci preoccupiamo anche di ciò che li deprime e li opprime, e speriamo con loro e per loro in un miglioramento della loro situazione. Quando stiamo davanti a Dio, non è solo la nostra vita che viene fuori nella preghiera. Così come la nostra vita è strettamente intrecciata con quella degli altri, così chiaramente le nostre preghiere fanno eco a preoccupazioni che non sono direttamente nostre, ma che in qualche modo diventano nostre a causa del nostro amore.

La solidarietà tra le persone trova così espressione non da ultimo nella preghiera. Nella preghiera dei fedeli, le necessità del mondo e di chi lo abita hanno un posto speciale nella liturgia. A questo punto della liturgia, i fedeli riuniti non pregano per se stessi. Questo posto è riservato, per così dire, a coloro che sono assenti, perché anche la comunità dei credenti, la chiesa, non è un’isola. Questo è dimostrato non da ultimo dalla vita quotidiana: nel nostro tempo, le persone interagiscono tra loro indipendentemente dalla denominazione, dalla religione e dalla visione del mondo. La Chiesa è in contatto con altre istituzioni e assume responsabilità in vari luoghi della società. La consapevolezza di questo legame tra la Chiesa e tutta l’umanità è probabilmente espressa nel modo più bello nel documento «Gaudium et spes» del Concilio Vaticano II del 1965. Il testo inizia programmaticamente: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo.»2
La solidarietà tra le persone trova così espressione non da ultimo nella preghiera.
Non è allora il sacerdote o chi guida la liturgia ad essere designato a portare le intercessioni della comunità davanti a Dio. Di solito lo fa chi legge le Letture del giorno durante la liturgia domenicale. Le intercessioni sono anche chiamate «preghiera universale» o «preghiera dei fedeli». Questo esprime la convinzione che tutti i discepoli e le discepole di Cristo sono chiamati e abilitati dal loro battesimo a partecipare attivamente alla liturgia nella lode e nella preghiera per il mondo.
Ma come possono le intercessioni arrivare a Dio e cambiare il mondo?3 O, per dirla in un altro modo, cosa succede quando i bisogni del mondo sono messi davanti a Dio nella comunità riunita?
Prima di tutto, la preghiera per gli altri manifesta una solidarietà che, si spera, non si limita alle parole. L’intercessione non è certamente un modo per evitare la responsabilità per il mondo, perché la questione è ora «depositata» presso Dio. Chi non si limita a cercare di portare a Dio una preoccupazione concreta, ma permette anche che il confronto con i bisogni «degli altri» faccia qualcosa in lui, uscirà cambiato dalla preghiera dei fedeli. Facendo spazio agli altri nella mia preghiera, anche la mia relazione con loro si approfondisce. Questo è particolarmente evidente quando ho una relazione personale con le persone per cui prego. Nel momento in cui condivido in preghiera la loro sofferenza, questi «altri» diventano parte della mia vita e della mia speranza, e quindi anche della mia relazione con Dio.

Il pastore e poeta bernese Kurt Marti (1921-2017) ha trovato le parole adatte per esprimere come la preghiera dei fedeli può essere intesa e praticata:
«La preghiera come intercessione può essere un tentativo di appropriarsi, di dirigere gli altri a distanza, ma può anche essere un’espressione di disarmata tenerezza, il desiderio di meditare amorevolmente su un’altra persona e sulle strade che prende.» 4
Nel momento in cui condivido in preghiera la loro sofferenza, questi “altri” diventano parte della mia vita e della mia speranza, e quindi anche della mia relazione con Dio.
Meditare amorevolmente su un’altra persona e sulla sua vita: anche questa è un’espressione di intercessione. Quando sono affezionato a una persona, allora sto amando, credendo e sperando allo stesso tempo. Nella vita quotidiana, mi faccio forza per le preoccupazioni di questa persona e faccio del mio meglio per il suo benessere. Nella preghiera, il luogo del mio dialogo con Dio, questo affetto si esprime, anche in considerazione dei suoi limiti. Non solo, ma soprattutto quando le mie possibilità di aiuto sono esaurite, metto davanti a Dio ciò che affligge e emoziona il mio prossimo e quindi anche me.
La relazione con i miei simili è il perno della mia preghiera. La mia preoccupazione, mossa dalla situazione dell’altra persona, mi spinge a pregare. Questa mia preghiera a sua volta rafforza il mio senso di unione con questa persona. Provate voi stessi!
- Così il titolo del suo libro. Cfr. Thomas Merton: Keiner ist eine Insel. Betrachtungen über die Liebe, Zürich 1979. In Italiano: Nessun uomo è un’isola, Milano, 1998.
- Cerca in: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html (11.10.2021).
- Cfr. Isabelle Senn: Bitte, https://glaubenssache-online.ch/2021/06/29/bitte/ (29.06.2021)
- Kurt Marti: Zärtlichkeit und Schmerz. Notizen, Frankfurt a. M. 71990, 117.
Crediti d’immagine: Copertina: Keystone / Immagine 1: frau.L., photocase.de / Immagine 2: pamone, photocase.de




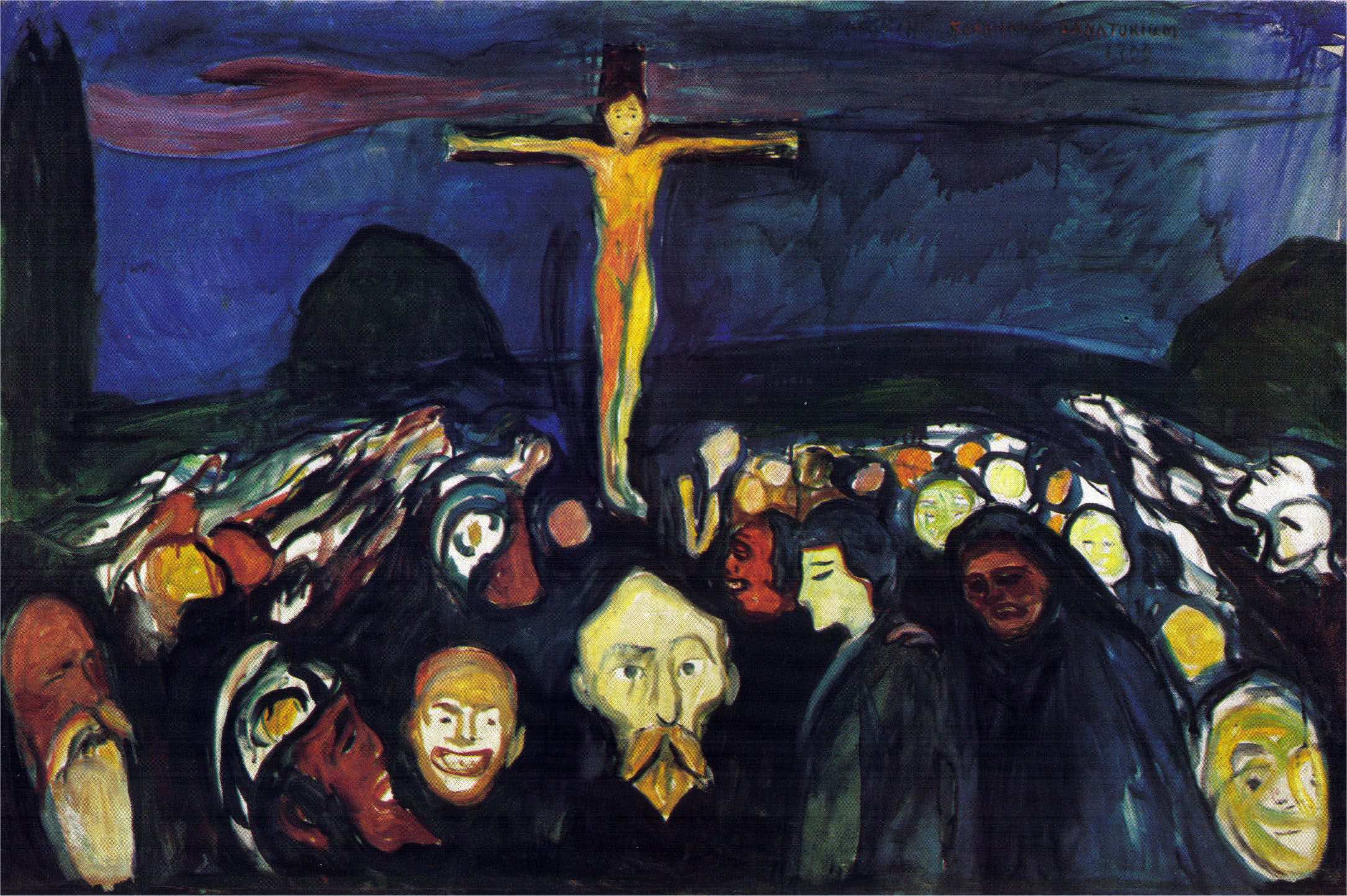
Commenti
Ancora nessun commento